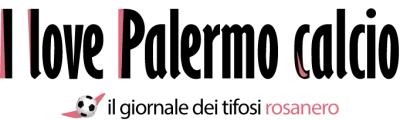Corriere dello Sport: “L’oro saudita non luccica più. Dubbi tra le star”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’Arabia Saudita.
Non è ancora una grande fuga, ma qualche timido tentativo di ritirata s’intravede. L’oro d’Arabia è diventato l’intrattenimento, perché i sauditi hanno capito che la dipendenza da una risorsa in esaurimento come il petrolio è un gioco a perdere; da qui “Vision 2030”, l’apertura ai diritti, il turismo, il calcio e gli investimenti sugli eventi. Quello del pallone è un oro che luccica, che attrae e invita a provarci. Perché, dopotutto, cosa vuoi che siano due o tre anni lontano dai grandi palcoscenici, come ha raccontato Milinkovic agli amici della Lazio mentre faceva le valigie e salutava Roma: «Torno in Europa a 31 anni e sarò ancora io».
E poi chissà che la fiche puntata sull’Arabia non possa pagare, più prima che poi. «Massimo 5 anni e questo diventerà uno dei tre migliori campionati al mondo» prometteva Ronaldo al suo arrivo all’Al-Nassr. Un Cristiano nella terra dell’Islam: rivoluzionario già nelle intenzioni. Pochi mesi dopo lo hanno raggiunto tra i tanti Mané, Fofana, Henderson, Koulibaly, Fabinho, Neymar, Kanté, Brozovic, Firmino, Malcom, Kessie, Ibañez e alcuni top della panchina come Steven Gerrard e Roberto Mancini. Per qualcuno è anche un affare di fede, visto che tra Riyad e Gedda tira forte il vento della religione, in quella che resta la culla delle due sacre moschee. Per un africano, in fondo, ricevere una barca di soldi a Madrid o a Gedda fa poca differenza se il livello resta comunque così alto e i modelli culturali restano diversi da quelli di un europeo che da bambino sogna di vincere la Champions.
Eppure, qualcuno sta mettendo in discussione la scelta fatta in estate. In Inghilterra parlano già di «ammutinamento» di Jordan Henderson, il cui trasferimento all’Al-Ettifaq, nel regno di Re Salman, fu pesantemente criticato visto il suo impegno concreto – in quello di Re Carlo – per i diritti LGBT. Il centrocampista guadagna 42 milioni a stagione ma ora rischia di non andare agli Europei e la sua squadra è solo ottava in Saudi Pro League: tornerebbe in Premier, di corsa. È la stessa idea di Gabri Veiga, il ragazzo che all’improvviso voltò le spalle al Napoli per dire sì ai 12 milioni annui dell’Al-Ahli. Anche lui vorrebbe tornare in Spagna, a qualsiasi costo. Il compagno di squadra Mahrez è un altro deluso, Ruben Neves dell’Al-Hilal strizza l’occhio alla Premier e si trova in una situazione inedita pure l’ex Pallone d’Oro Benzema. A fine dicembre il francese aveva fatto perdere le proprie tracce, secondo gli arabi «aveva solo chiesto dei giorni di riposo», ma di sicuro i 9 gol segnati nel campionato anonimo dell’Al-Ittihad campione in carica, oggi settimo a -25 dalla capolista Al-Hilal, lo stanno convincendo a riflessioni profonde.
Sono i primi colpi di assestamento di un modello che sta ancora cercando una dimensione: perché i soldi non possono bastare a costruire un progetto vincente e l’Arabia, anche solo climaticamente e socialmente, è tutto un altro mondo per chi arriva dal vecchio continente. Di sicuro sbaglia chi ritiene quello saudita un fuoco di paglia. Gli investimenti sono concreti e a lungo termine (quasi 2 miliardi tra ingaggi e cartellini in estate, nel 2034 ci sarà qui il Mondiale), la differenza con gli esperimenti cinesi e russi, dove mancava il trasporto popolare e i soldi li mettevano aziende private, è netta e la voglia di raggiungere la Premier League resta l’obiettivo principale. Testardamente, e con i loro tempi, i sauditi sono ancora convinti di poter scardinare le gerarchie della geopolitica del calcio.