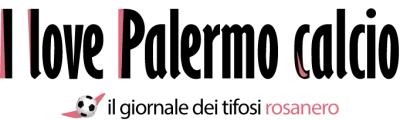Addio a Schillaci. Butera: «Avrebbe voluto finire la carriera giocando nel suo Palermo. Al Barbera ci è entrato dentro una bara»
Quell’estate, all’improvviso, diventammo tutti Totò. Grandi e piccoli, non c’era differenza. Eravamo tutti Totò, con i suoi occhi spiritati e assetati di gol, come chi cerca acqua nel deserto. Era l’estate del ’90, il Mondiale italiano aspettava altri eroi (Maradona, Baggio, Matthäus, Van Basten, Romario), ma il dio del calcio – da sempre birichino – decise di puntare il suo sguardo su quel numero 19 arrivato da Palermo. E, come per magia, il bruco divenne farfalla. Spiccando il volo nei cieli della gloria eterna

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Butera si sofferma sulla scomparsa di Totò Schillaci.
Un gol contro l’Austria, poi un altro, fino a diventare il capocannoniere di quel Mondiale che l’Italia perse per un colpo di testa galeotto di Caniggia e un’uscita sfortunata di Zenga contro l’Argentina. A Totò Schillaci mancò la ciliegina sulla torta, quella che aveva reso ancora più dolce il Mundial spagnolo di Pablito Rossi otto anni prima. Ma Totò era già leggenda, e non come il personaggio immaginario del “Bar Sport” di Benni, ma come il “picciotto” del Cep, che conquistò il mondo con i suoi gol, le sue esultanze, e quei suoi occhi spiritati, che rimarranno impressi per sempre nella memoria collettiva.
La sua strada verso l’Olimpo del calcio partì da un campo polveroso del Cep, come un emigrante qualunque, con una valigia piena di sogni e speranze. Da Messina, partita dopo partita, gol dopo gol, Schillaci arrivò alla Juventus, poi all’Inter, passando per la Nazionale e quel Mondiale esagerato, che lo consacrò eroe. La sua “cazzimma”, la furbizia delle strade popolari, lo rese capace di raggiungere vette impensabili. Cresciuto tra palazzi popolari e gente che lavorava duramente per portare a casa un pezzo di pane, Schillaci sapeva cosa significava il sacrificio: lo vedeva nelle mani del padre muratore. Per lui, il calcio era l’unica via, l’unica strada, sia che si trattasse di un campo di quartiere o del Ferruzza, oggi Ribolla.
Nonostante il suo fisico non fosse quello di un corazziere, Schillaci era un attaccante puro, capace di sorprendere con il suo fiuto per il gol. Come scriveva Osvaldo Soriano, ci sono tre tipi di calciatori: quelli che vedono gli spazi già esistenti, quelli che riescono a vedere spazi che gli altri non notano, e poi ci sono i poeti del gioco, che creano spazi dove non dovrebbero esserci. Totò apparteneva alla seconda categoria: vedeva spazi che nessun altro notava, e li sfruttava con un istinto innato che non si impara, ma si ha nel DNA.
All’Amat, la società dove crebbe calcisticamente, se ne accorsero subito. I suoi allenatori, Mario Falanga e Angelo Chianello, non gli riservarono mai trattamenti di favore, ma gli insegnarono l’importanza del rispetto, sia verso i compagni che verso gli avversari. Lezioni che Totò non dimenticò mai, portandole con sé quando approdò alla Juventus e poi all’Inter.
Il calcio è fatto di gioia e di lacrime, di drammi e di esaltazione, e Totò ne fece esperienza durante una carriera che lo portò fino in Giappone, dove fu il primo italiano a giocare nella terra del Sol Levante. In Giappone, Schillaci cominciò la sua lenta discesa, ma con un rimpianto: non giocò mai con il Palermo, la squadra della sua città. Avrebbe voluto chiudere la carriera vestendo la maglia rosanero, ma quello fu l’unico sogno che rimase nella sua valigia, quella con cui era partito dal Cep. Al Barbera è entrato solo per eventi benefici, e oggi ci è tornato, ma dentro una bara. Il destino sa essere crudele, quanto sorprendente.
Proprio come quel Mondiale del 1990, in cui l’Italia si innamorò di Totò, il ragazzo dagli occhi spiritati che diventò l’eroe popolare di un’intera nazione. Nemmeno la morte potrà spegnere il suo ricordo. Totò Schillaci resterà immortale, un simbolo di speranza per tanti ragazzi che, come lui, sognano di farcela partendo dal niente. Buon viaggio, campione.